Perché fare attenzione alle parole che si usano nel discorso pubblico non è un lusso ma una necessità? Il linguaggio usato per narrare e riflettere sul fenomeno del femminicidio mostra ancora una volta come abbiamo la possibilità di agire solo su ciò che siamo in grado di nominare correttamente.
Domenica 19 novembre a Vigonovo, piccolo paese in provincia di Venezia, regna un silenzio surreale. Una signora di fronte a me, con una fiaccola tra le mani, sussurra all’orecchio del marito: “Come è strano, si sentono solo le scarpe quando la gente si muove...”. È il suono dei passi discreti delle migliaia di persone riunite in memoria di Giulia Cecchettin, rapita e uccisa dall’ex fidanzato una settimana prima.
Quella di Cecchettin è solo l’ultima variante di una storia sentita tante, troppe volte, in ciascuno dei più di 100 casi di femminicidio avvenuti in Italia dall’inizio del 2023 a oggi. Questa volta, però, forse perché ad essere evocati sono nomi e luoghi a me familiari, la storia mi ha toccata in un modo che supera l’usuale empatia che si prova di fronte alle vittime di un crimine. Ad essere risvegliato in me è stato invece quel corpo di dolore simbolico che le parole di Maura Gancitano e Andrea Colamedici riassumono così bene:
Si riaccende una memoria, anche se quella violenza non l’abbiamo mai provata in questa vita. È una memoria che attraversa le generazioni, ed è ovviamente legata a una rabbia che le donne portano dietro e che non riguarda solo loro. Quel corpo di dolore – quell’insieme di emozioni che si riaccendono in casi come questi – può essere sciolto a livello individuale, certo, in modo da poter vivere più serenamente le nostre vite personali, ma è importante riconoscere quanto sia legato al bisogno di giustizia, e quanto porti con sé una rabbia necessaria […].
In questi giorni mi sono spesso domandata cosa avessi potuto fare per dare voce a questo corpo di dolore che io e tante altre donne abbiamo provato e che continuiamo a provare. Ho deciso quindi di partire da ciò di cui filosoficamente mi occupo più spesso: le parole.
Le riflessioni sul linguaggio, fra le battaglie femministe del nostro tempo, sono forse quelle additate più spesso come questioni marginali, superflue – quasi un capriccio intellettuale – sull’onda di fondamentalmente due idee: la prima, che le parole sono “solo parole”, e dunque non contino in modo sostanziale nel risolvere problemi, e, di conseguenza, la seconda, ovvero che “i problemi sono ben altri” (anche se in questo caso gli obiettori solitamente mancano di specificare quale sia il “vero problema”, come se poi, si potrebbe aggiungere, l’esistenza di un problema ne delegittimasse automaticamente un altro).
Entrambe le obiezioni sottintendono quindi l’idea che le parole che usiamo non impattino sulla realtà che ci circonda. Ma le parole contano eccome. Il linguaggio che usiamo quotidianamente ha infatti l’enorme potere di tracciare un confine tra cosa, nel nostro spazio sociale condiviso, è esistente, accettato o rifiutato, e cosa invece non esiste affatto. Questo significa che chiamare le cose con il proprio nome ha il ruolo fondamentale di validarne e riconoscerne l’esistenza; e, di conseguenza, di poterle affrontare.
Secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili in relazione alla percezione da parte delle vittime della violenza subita (i più recenti, purtroppo, relativi all’anno 2014), delle donne che hanno subìto violenza fisica o sessuale da un partner o ex partner, solo il 29% ritiene di essere stata vittima di un reato, mentre il 44% sostiene che si è trattato di qualcosa di sbagliato ma non di un reato. Ancora, il 19,4% considera la violenza solo qualcosa che è accaduto.
Come si può immaginare, chiamare una violenza sessuale “reato” o semplicemente “qualcosa che è accaduto” apre scenari molto diversi: un reato in quanto tale è denunciabile, condannabile e perseguibile. Un reato riconosciuto come tale implica un processo penale, rieducativo per chi lo commette e un percorso di aiuto, ascolto, sostegno per chi lo subisce. Un “qualcosa che accade” al contrario, appartiene con ineluttabilità al naturale corso degli eventi: non vi è condanna, responsabilità, distanziamento, elaborazione.
Diventa allora essenziale usare la parola “femminicidio”, e non “delitto passionale”, o “raptus di gelosia”. O ancora, come ha fatto notare con estrema lucidità Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, descrivere l’assassino di una donna non come un mostro, un folle, un fuori di testa, ma come “il figlio sano del patriarcato”.
Perché sbagliare parola significa non vedere come quella che sembra l’eccezione alla regola o la personalità divergente sia invece la regola stessa. Significa non riconoscere che episodi di violenza fisica e sessuale contro le donne non sono casi isolati, scollegati, nati dalla furia, dalla gelosia o dalla “mostruosità” di un singolo, ma sono la trama di un quadro più ampio in cui il femminicidio è la punta più violenta di un iceberg strutturale che tutte e tutti noi abitiamo. Significa, ancora, continuare a pensare che quella dei femminicidi, come diversi giornali hanno titolato, sia “un’emergenza”, un evento inaspettato ma momentaneo, e non, come invece è, un pattern che vediamo ripetersi ancora e ancora in un ciclo di violenza sistemica.
Cosa ci dice tutto questo? Questi dati ci dicono che chiamare le cose con il proprio nome aiuta ad aumentare la consapevolezza di ciò che viviamo e a cui assistiamo. La parola che scegliamo per riflettere, narrare una vicenda o agire di conseguenza, darà forma a prospettive di riflessione e di azione diametralmente diverse.
Con grande lucidità, Michela Murgia ha sottolineato come una delle più grandi tragedie del nostro tempo sia proprio la tragedia semantica, cioè il problema del significato che le parole assumono. Essa è drammatica e dolorosa perché è prima di tutto una tragedia etica:
[…] nella nostra quotidianità essere etici significa soprattutto scegliere di trattare le cose nominate così come le abbiamo nominate. Sbagliare nome vuol dire sbagliare approccio morale e non capire più la differenza tra il bene che si vorrebbe e il male che si finisce a fare. […] il modo in cui nominiamo la realtà è anche quello in cui finiamo per abitarla.
Al contrario, “sbagliare nome” vuol dire categorizzare fatti, esperienze, persone, secondo criteri e aspettative inadeguate a ciò che tali realtà effettivamente sono. Come scegliere allora le parole per narrare, riflettere, costruire?
Per chi cercasse una serie di indicazioni pratiche è utile consultare il Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell’informazione, siglato a Venezia nel 2017. In relazione al tema della narrazione dei femminicidi, al punto 10, le firmatarie e i firmatari sostengono che è necessario evitare:
a) espressioni che anche involontariamente risultino irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell’identità e della dignità femminili;
b) termini fuorvianti come “amore”, “raptus” ,“follia”, “gelosia”, “passione” accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento;
c) l’uso di immagini e segni stereotipati o che riducano la donna a mero “richiamo sessuale” o “oggetto del desiderio”;
d) di suggerire attenuanti e giustificazioni all’omicida, anche involontariamente, motivando la violenza con “perdita del lavoro”, “difficoltà economiche”, “depressione”, “tradimento” e così via;
e) di raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole, partendo invece da chi subisce la violenza, nel rispetto della sua persona;
A leggere i titoli di giornali usciti in questi giorni, sembra che il manifesto sia sconosciuto a buona parte di coloro che scrivono. Chiunque, nonostante e in virtù di ciò, voglia approfondire la questione, ne trova una copia alla fine di questa pagina.
In conclusione a questo articolo vorrei, infine, proporre due percorsi “uditivi” a chi sta leggendo. Qui sotto trovate due tracce audio. La prima è una registrazione del suono dei passi, del silenzio, dei respiri di più delle quattromila persone che si sono ritrovate a ricordare Giulia Cecchettin alla fiaccolata nel suo paese. Questa traccia è per chi sente il bisogno di raccogliersi, riflettere, guardare dentro di sé e interrogarsi su cosa, ciascuna e ciascuno, possa fare.
La seconda è un estratto del minuto di rumore che le colleghe e i colleghi universitari di Cecchettin hanno deciso di dedicarle nel momento di ricordo indetto dall’Università di Padova, da lei frequentata, raccogliendo l’appello della sorella: “Per Giulia, non fate un minuto di silenzio. Per Giulia bruciate tutto”. Questa seconda traccia è per chi dentro di sé sente una grande rabbia, un desiderio esplosivo di abbattere ostacoli, muri, per ricostruire, ricreare, rinnovare.
Qualunque strada scegliate, sia essa silenzio o rumore, il mio augurio è che poi si trasformi in parola, ma non in una parola qualsiasi. Come ci insegna ancora una volta Murgia, di fronte alla difficoltà di scegliere le parole per narrare, riflettere, costruire, è bene tenere a mente che “il solo modo per riconoscere le parole giuste è guardare se fanno giustizia”. Giustizia per Giulia e per tutte quelle donne che oggi non hanno più voce per chiederla.
Copertina di Adele Bilotta, su Instagram @adeliocompresso.
Fonti bibliografiche:
- "Il nostro corpo di dolore", @tlon.it: https://www.instagram.com/p/CwKWJnGARDU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==;
- M. Murgia, Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più, Einaudi, Torino 2021;
- Perchè usiamo la parola femminicidio, puntata del podcast Amare parole di Vera Gheno, per Il Post;




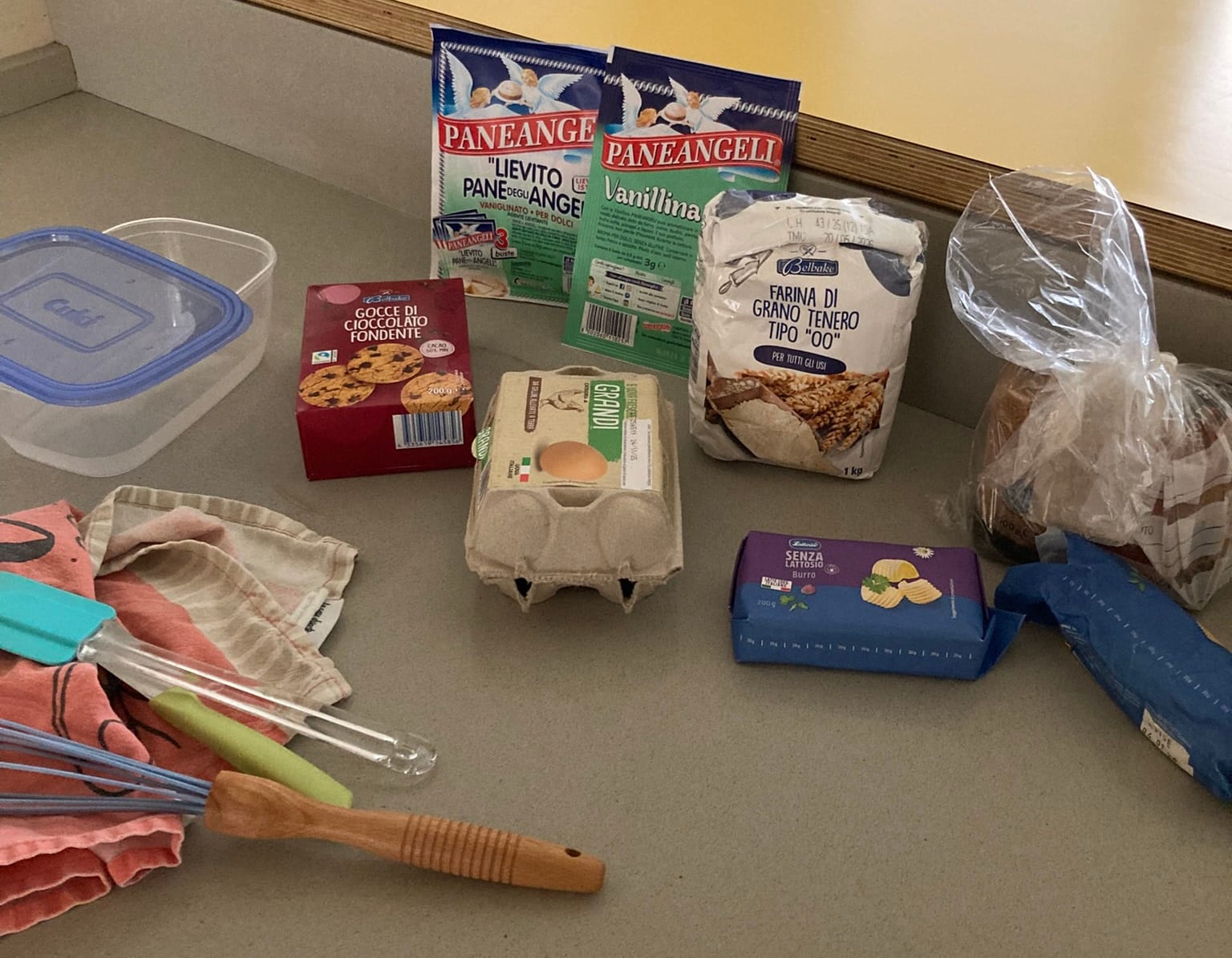
Comments ()