Come mai per legittimarsi in alcune professioni le donne si presentano al maschile?
Venerdì 6 ottobre, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, giornata nazionale della comunicazione: esperte ed esperti delle principali università italiane si incontrano a Bologna per condividere idee ed esperienze sulla «funzione pubblica della comunicazione». Si tratta di un’occasione per confrontarsi sui possibili orizzonti lavorativi, che si aprono a un laureato e a una laureata in questo settore, e sulla definizione della funzione pubblica di un comunicatore. Scrivo comunicatore perché nonostante nelle università di comunicazione vi siano studenti e studentesse da cui escono, dopo la laurea, comunicatori e comunicatrici, negli interventi si parla solo di comunicatori, al maschile. Non è solo la figura del comunicatore-maschio ad aleggiare in Aula Poeti, di fianco a lui domina quella del relatore, anche lui maschio. Non basta nemmeno la presenza maggioritaria di relatrici di sesso femminile perché si dia rappresentanza a entrambi i sessi. Sono molte infatti le relatrici che, al momento dell’accoglienza e durante gli interventi, si presentano in quanto relatori: i protagonisti indiscussi di questa giornata sono dunque i futuri comunicatori e i relatori. È necessario attendere il pomeriggio e l’intervento delle professoresse Capecchi e Vaccari per riportare il genere femminile sulla scena e ricordarci che non siamo solo in presenza di comunicatori, ma anche di comunicatrici.
Si potrebbe pensare che queste osservazioni non facciano altro che concentrarsi su meri formalismi linguistici, privi di ripercussioni sul reale, e che il linguaggio sia un semplice strumento utilizzato per nominare qualcosa. Tuttavia quella che appare come una semplice nominazione di una parte di realtà corrisponde a una forma di riconoscimento di un’esistenza. Non avere un termine per essere nominate significa non essere riconosciute nella propria esistenza. E non essere riconosciute nell’esistenza significa non esistere socialmente. Ecco perché il fatto che una donna, per presentarsi nel proprio lavoro, senta il bisogno di dirsi al maschile è un fenomeno che necessita di essere osservato con attenzione. Come mai per legittimarsi nella propria professione talvolta le donne si presentano al maschile? Come mai accademiche della comunicazione, esperte cioè - tra le altre cose - di modalità espressive e forme linguistiche, si presentano al maschile quando si tratta di lavoro?
I femminili professionali sono espressioni linguistiche che provocano stupore e che appaiono come insoliti. Questi femminili vengono spesso additati come neologismi, come distorsioni cacofoniche della lingua italiana; in realtà Vera Gheno, in Femminili singolari, osserva come essi siano forme morfologicamente previste dalle regole della lingua italiana che tuttavia appaiano come strani poiché inusuali. Tali espressioni appaiono come nuove, e di conseguenza insolite, non in ragione di una loro effettiva novità, ma a causa del loro mancato utilizzo. É nell’attuale circolazione di tali espressioni che risiede la loro novità. Dal momento che «noi esseri umani, normalmente, sentiamo il bisogno di nominare ciò che vediamo (o ciò che ci immaginiamo), non ciò di cui non abbiamo esperienza», il fatto che fino ai tempi recenti mancassero persone che potessero essere designate con i professionali femminili ha causato la mancata circolazione di tali forme linguistiche, sebbene esse esistessero. Il problema dunque, più che essere linguistico, è di natura sociale, culturale e psicologica: è l’asimmetria esistente in ambito lavorativo tra uomo e donna che provoca un’asimmetria delle forme linguistiche.
Come mai le donne sentono la necessità di presentarsi al maschile quando incarnano alcune cariche lavorative e vogliono legittimarsi in quelle vesti specifiche? Tale necessità è legata al tipo di lavoro esercitato? Se sì, come mai? Non tutti i lavori suscitano l’urgenza di nascondere la propria appartenenza al genere femminile attraverso l’uso del maschile. Vi sono molti lavori che si dicono sia al femminile che al maschile, la cameriera e il cameriere per esempio; tuttavia molti altri sono segnati da un’appartenenza specifica a un genere. L’infermiere è femmina, mentre il medico è maschio, la segretaria è femmina mentre l’avvocato è maschio, la maestra è femmina mentre il professore è maschio, mentre il dirigente scolastico è maschio, mentre il rettore universitario è maschio. Cos’è che si dice al maschile? Tutto ciò che si trova su un scalino più alto nella scala gerarchica; tutto ciò che riveste una carica di potere. Questo perché il potere è maschio - o così è come appare e si configura. Tale rapporto di esistenza non è un rapporto essenziale da intendersi in maniera naturalizzata: il potere non è maschio in senso naturale, non vi è alcun ordine superiore che imponga che il potere debba essere maschile, benché sia esattamente così che lo si voglia far apparire e presentare.
Il potere è maschio perché nel contesto sociale in cui abitiamo è stato costruito al maschile. Per potere non intendo qualcosa che scaturisce da un singolo individuo attraverso l’emanazione di leggi positive, ma designo, seguendo Foucault, un sistema relazionale che opera in ogni anfratto della società attraverso una regolamentazione sistematica degli spazi, del tempo e delle attività andando a orientare i comportamenti e la materialità degli individui e della società nel suo insieme. Il potere ha infatti, in quest’ottica, una duplice azione: è normativo e produttivo. Tramite la regolamentazione esso si configura come prescrittivo, ovvero stabilisce obblighi o divieti, e allo stesso tempo come produttivo. Produce ciò che si impegna a regolamentare.
Poniamoci dunque la seguente domanda: che cosa produce? Produce una sfera di potere tutta maschile. Il politico è maschio, l’avvocato è maschio, il giudice è maschio. Figure professionali che inglobano in sé potere e prestigio, al punto che se una donna, dopo anni di lotta per avere accesso a certe cariche lavorative, riesce a ottenere un incarico di potere, ancora oggi per legittimarsi in essa nasconde il proprio essere femminile presentandosi al maschile. Infatti Gheno osserva come, per alcune professioni, sia la donna stessa a sentirsi declassata dall’uso del femminile: «è la donna stessa a sentirsi squalificata dall’uso del femminile, come se al titolo professionale maschile venisse dato un valore maggiore; (…) sentendosi “meno” del maschio, ecco che preferisce essere nominata come il maschio». E il potere cosa produce al femminile? Cos’è che si dice al femminile? Infermiera, psicologa segretaria, maestra, commessa, donna delle pulizie, babysitter. Cos’hanno in comune questi lavori? Si tratta di impieghi accumunati dal senso di cura e di aiuto, perché l’essere servizievole è femmina. Dirsi al femminile rimanda all’idea della cura, dell’emotività, del soccorso, del trovarsi su uno scalino più in basso sempre pronte a prendersi cura dell’Altro - come se vi fosse qualcosa di non-costruito e di naturale a definire e stabilire la differenza tra donna e uomo, come se non fosse l’organizzazione stessa del sistema a imporre un’educazione diversa a uomo e donna sulla base di una differenza di genitali, e a determinare così la diversa maniera con cui le persone entrano in società, si presentano e si relazionano tra di loro.
Il linguaggio dunque è molto più di uno strumento di semplice nominazione. Esso rimanda a un insieme di significati che plasmano la realtà. Quando dico « donna», non mi limito a nominare una persona socializzata in quanto donna, ma mi riferisco all’insieme di significati racchiusi in questo termine. Attraverso la parola noi non ci limitiamo a indicare una cosa, ma la portiamo a essere, la performiamo. Parlare di comunicatore e di relatore solo al maschile significa performare una realtà tutta al maschile, significa plasmare come unicamente maschile quell’ambito lavorativo in cui si gode di una certa visibilità e di una buona dose di potere; significa dire che per essere ascoltati e per poter parlare legittimamente bisogna essere maschio.
Si potrebbe obiettare a tutto ciò dicendo che il maschile include in sé anche il genere femminile, come ci indicano le regole della grammatica italiana quando si parla di insiemi o di raggruppamenti di persone. A chi sostiene queste argomentazioni è importante ricordare che si deve distinguere tra il genere grammaticale, dettato dalle regole sul funzionamento della lingua, e il genere semantico, che ci dice che il genere della parola segue quello di ciò che designa. A ciò aggiungo due cose, la prima è che in quel maschile il genere femminile non si sente rappresentato e la seconda, di maggior importanza, è che in quel maschile universale si celano rapporti di forza e di potere inglobanti e schiaccianti che vanno scoperti e scardinati. Indicare le professioni al maschile con la pretesa di non dare importanza alla differenza di genere rischia di far passare in sordina l’effettiva asimmetria esistente tra uomo e donna, con l’unico risultato di perpetuare gli squilibri esistenti. Gheno a tal proposito nota come il genere arriverebbe effettivamente a non contare se arrivassimo a chiamare tutte le professioniste al femminile esattamente come chiamiamo al femminile, senza alcuna esitazione, le donne in professioni in cui siamo abituati alla loro presenza. Non è dunque la generalizzazione del maschile ciò verso cui dovremmo muoverci, ma l’obiettivo dev’essere la normalizzazione di una duplicità di genere in tutti gli ambiti professionali.
Assumere il maschile come universale significa perpetuare una sfera simbolica in cui il femminile rimane una parte minoritaria del maschile-universale, il sottogruppo di un tutto, l’eterno altro all’interno dell’umanità. Questo fa sì che potere, prestigio e visibilità rimangano e si consolidino come ambiti di competenza unicamente maschili, inducendo le donne a presentarsi al maschile per legittimarsi in quelle professioni socialmente riconosciute come maschili. Per parlare legittimamente davanti a una platea di argomenti che hai studiato, hai approfondito, su cui hai riflettuto, e per poter sperare di essere ascoltata e presa sul serio devi presentarti al maschile.
E se si provasse a parlare al femminile universale almeno nei gruppi a maggioranza femminile? Mi è capitato, in un gruppo-studio tutto composto al femminile, di ritrovarmi a cambiare genere di designazione linguistica dello stesso in seguito all’accesso di un collega maschio nel gruppo. Nominare un gruppo di otto persone, composto da sette ragazze e un solo ragazzo, al maschile significa riconoscere nuovamente e continuamente un posto e una visibilità di privilegio al maschio. Tutta la componente femminile del gruppo è così inglobata nell’aurea del maschile-universale per la presenza di un singolo ragazzo. La nominazione al maschile del gruppo tradisce il reale, performando una nuova realtà tutta maschile. Interpellare le professioni di esercizio di potere al maschile significa confermare senza sosta una forma tutta maschile del prestigio e della visibilità, delegando al femminile ruoli di assistenza, e suggerendo così ruoli di potere da vivere sempre e solo in vesti maschili.
Bisogna prestare attenzione alle parole che vengono adottate nella comunicazione poiché esse hanno un potere plastico sul reale. Dietro a ogni parola si annida un mondo di significati, che celano scale gerarchiche di dominio e di pregiudizi, che attraverso un uso ripetuto e reiterato diventano stereotipi. La lingua italiana è una lingua viva e come tale è giusto che si comporti: il mondo, per fortuna, sta cambiando e sotto la spinta di lotte e manifestazioni le donna stanno avendo accesso a sempre più ambiti professionali. È necessario dunque che la lingua registri e si faccia veicolo di tale cambiamento, favorendo la circolazione di termini al femminili e un parallelo slittamento di significati.



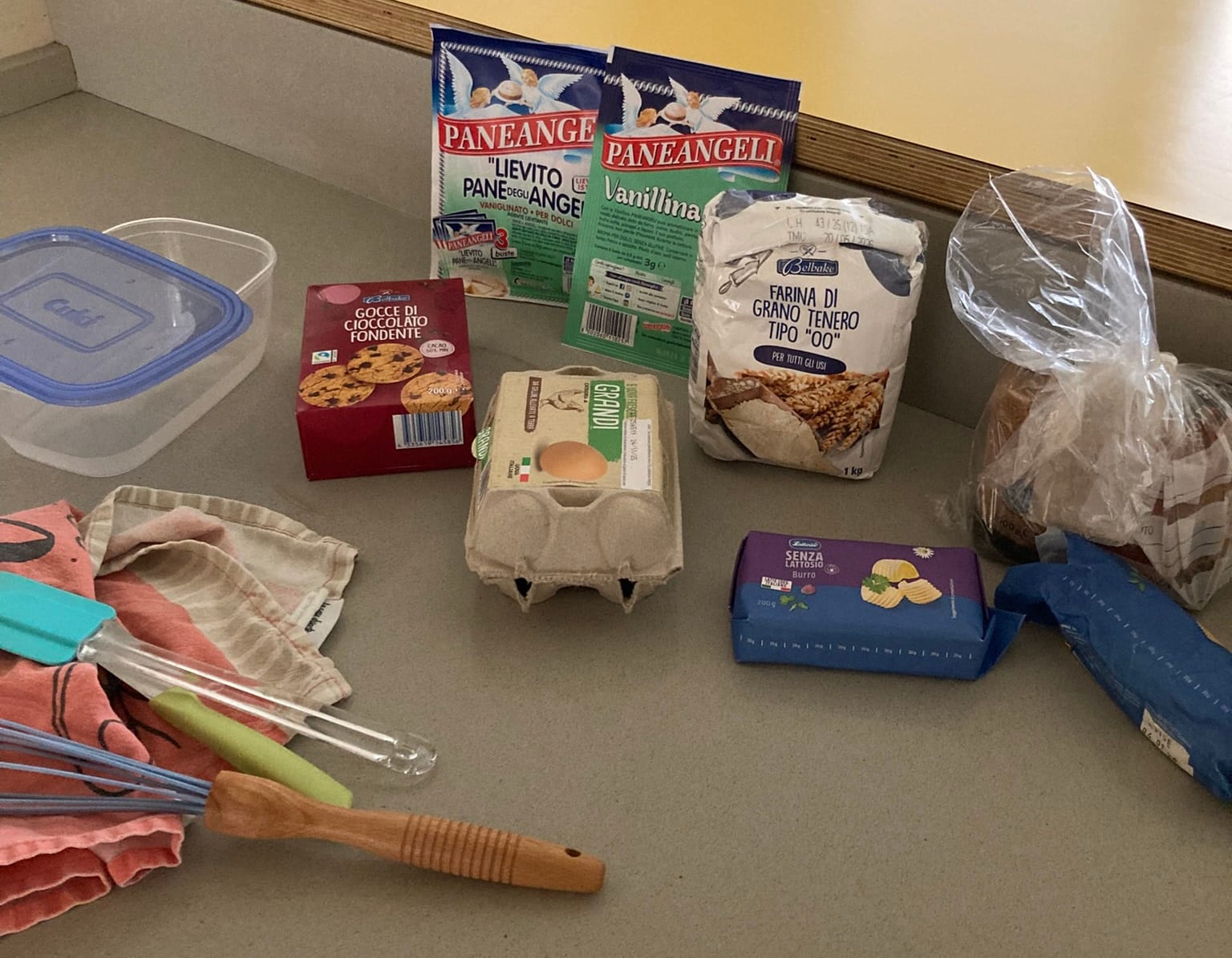
Comments ()