Nella società di oggi, dominata dalla logica del profitto e della prestazione, le scelte concrete sono determinate dalle esigenze del sistema e portano all’alienazione. Occorrerebbe, invece, ripensare il lavoro e il tempo libero nei termini di un’autentica espressione della propria essenza.
La band Lo Stato Sociale, nella canzone Una vita in vacanza, canta “vivere per lavorare o lavorare per vivere?”. Proprio questa è la domanda che oggi sempre più ragazzi si pongono. Perché lavorare? Cos’è il lavoro? Ma soprattutto, quali sono i criteri sulla base dei quali sceglierlo? In aggiunta, un'altra questione fondamentale è anche quella della dignità. Che cosa rende degna una professione? Cosa rende degne le persone?
L’Articolo 1 della nostra Costituzione recita: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, ma la maggior parte delle professioni e dei lavoratori sono oggi sminuiti, sottopagati e vittime di discriminazione sociale o di pressioni psicologiche. A tutte queste aspettative e ansie, espresse sottoforma di commenti più o meno innocenti da parte degli attori sociali che ci circondano, siamo sottoposti sin dall’infanzia. Questo non può che influenzare le nostre scelte formative, lavorative e la condizione della nostra psiche. Oggi, infatti, consciamente ma anche inconsciamente, il criterio principale che guida questo genere di scelte è quello dell’approvazione sociale. I lavori che vengono ritenuti maggiormente appaganti e soddisfacenti sono quelli di cui i nostri nonni sarebbero fieri, quelli che ci garantiscono i complimenti da parte di uno sconosciuto al bar o le congratulazioni degli amici di parenti lontani. Nessuno ascolta più la sua interiorità, forse perché nessuno ormai la conosce. Perché non compiamo queste scelte utilizzando la nostra felicità come criterio? Perché non cerchiamo un lavoro che ci consenta di esprimere noi stessi nel mondo, di lasciare un’impronta con le nostre identità?
Facendo riferimento al concetto di entelechia di Aristotele, ciascuno ha una tensione a realizzarsi secondo le sue proprie leggi, una tendenza a sviluppare la sua propria essenza, ad essere compiutamente sé stesso. Per l’uomo, come afferma l’autore nell’Etica Nicomachea, il riuscire ad essere sé stesso è la felicità. Ma come può l’uomo contemporaneo esprimere la sua essenza se il dominio pervasivo delle coscienze, espresso in maniera soft dall’industria culturale, ha proprio l’obiettivo di renderlo alienato, inconsapevole e ottenebrato? Perché una persona che sceglie di lavorare come cassier* part time per avere tempo da dedicare a se stessa, a cause umanitarie, a saziare la sua fame di cultura, ad abbeverare il suo spirito, ad educare i suoi figli (che tra l’altro saranno i futuri cittadini del nostro Paese) è considerata una fallita? Al contrario, abbiamo la tendenza a lodare un* manager che lavora in un’azienda anche dodici ore al giorno e che non prova nessun interesse verso il prossimo, verso la sua comunità, verso la storia, che non ha tempo da dedicare alle sue passioni e che quindi spesso non è nemmeno consapevole di che cosa l* faccia sentire autenticamente realizzat*, o che talvolta sente addirittura di non conoscere i suoi figli. Nel sentire comune, paradossalmente,un individuo del genere viene reputato qualcuno che nella vita ha vinto tutto, che ha avuto successo ed è da ammirare.
Ma che cosa rende un lavoro degno? E da cosa dipende la differenza di stipendio? Qualcuno potrebbe dire che i compensi dipendono dalle competenze necessarie, dalla quantità di studio e di energia cognitiva che occorrono per svolgere quel determinato lavoro. Purtroppo, però, oggi non è così. Un ingegnere con una laurea triennale, con competenze ed esperienze altamente specializzate ma anelastiche, viene visto come estremamente superiore, di maggior successo e viene pagato molto più profumatamente rispetto ad umanisti che magari hanno studiato per molti più anni e hanno una conoscenza approfondita di determinate civiltà, società, periodi storici, ecc., capaci di svolgere una vasta gamma di lavori che mettono in gioco una rosa di competenze molto più ampia. Ovviamente questa è una generalizzazione che non vuole sminuire il reale interesse di alcune persone nei confronti di determinate discipline, ma solo sottolineare il peso e la rilevanza di alcuni aspetti piuttosto che altri nel prendere le decisioni. Tutto questo può essere ricondotto alla logica di profitto imperante nella società capitalistica in cui viviamo, logica che è funzionale alla sopravvivenza del sistema stesso.
Nell’ambiente socioculturale in cui siamo immersi, infatti, tutto viene valutato su base prestativa, dal lavoro alla famiglia, dallo studio alle attività ludiche. Herbert Marcuse, facendo riferimento alla società contemporanea, parla infatti di “principio di prestazione”. Questo, secondo l’autore, è ciò che rende l’essere umano un puro ingranaggio, un essere per la produzione; tale individuo, caratterizzato da un'esistenza trascorsa a calcolare costi e benefici di ogni azione attraverso la ragione strumentale e a cercare unicamente il profitto, appare inconsapevole di quello che Heidegger definisce il suo “essere per gli altri”. Il profitto è diventato oggi il criterio della felicità. E un profitto maggiore è ovviamente quello generato dalle professioni che garantiscono lo sviluppo del sistema, che consentono alla macchina del consumo di procedere sempre più veloce e generare sempre più guadagno, anche a spese degli altri. Per questo è inevitabile che tutti gli strumenti di produzione e propagazione dell’ideologia capitalista presentino alcune professioni, come quella di ingegnere automatico o robotico, come infinitamente più desiderabili rispetto a quella, ad esempio, di professore di storia e filosofia. Le professioni più utili al sistema sono ovviamente incentivate anche da stipendi più alti, da maggiori garanzie lavorative e da un numero elevato di comfort offerti. Al contrario, alcuni mestieri sono disincentivati proprio per il loro rischio eversivo e sovversivo, in quanto favoriscono il risveglio delle coscienze e la messa in discussione del sistema e quindi del dominio della classe dominante.

Oggi chi si ribella è chi sceglie se stesso, chi decide di fermarsi ad ascoltare la sua vocazione personale e di anteporla alla logica della competizione e del profitto. Chi si ribella, però, è costretto a vivere con l’ansia di non arrivare a fine mese, di non poter mantenere i propri figli e di dover rinunciare, per esempio, ad esperienze formative. A questo si aggiunge una forte pressione sociale e psicologica che deriva dal doversi scontrare quotidianamente con il giudizio e la critica di tutti coloro che, alienati dal lavaggio del cervello mediatico che subiamo costantemente, non riescono a vedere un’alternativa, una vita che non si fondi sulla prestazione.
È vero che il lavoro consente il riconoscimento di se stessi, come si evince chiaramente dalla figura di signoria e servitù, presentata da Hegel nella Fenomenologia dello Spirito. Attraverso questa figura, infatti, egli sottolinea come la trasformazione della realtà esterna tramite il lavoro sia indispensabile affinché la nostra coscienza giunga a se stessa. È altrattanto vero, però, che per come è concepito e strutturato il lavoro oggi c’è il rischio che porti, invece, all’annullamento e all’annientamento delle nostre stesse identità. Persi dietro al rincorrere i soldi e il riconoscimento altrui, non vediamo più la nostra natura. Non ci accorgiamo che il nostro tempo può essere utilizzato per esprimere noi stessi nel mondo, per portare a compimento quello che siamo in un modo che possa farci sentire realizzati e che possa portare benefici all’intera comunità di cui facciamo parte o all’intera umanità. Non realizziamo più che oltre al lavoro per il profitto ci possa essere altro, che il lavoro non debba necessariamente essere una gabbia generatrice di stress e che la dignità di un lavoro non dipende dalla sua considerazione sociale.

Il continuo sottolineare che il profitto e l’approvazione sociale devono essere i criteri e gli obiettivi centrali esercita una pressione incredibile sui giovani nella scelta del loro percorso formativo, crea disturbi di ansia generalizzata, spinge ad un’isteria di massa di cui siamo inconsapevoli e talvolta induce persino al suicidio. Questo, nella maggior parte dei casi, avviene però in maniera inconsapevole, non intenzionale e per questo più subdola, tramite commenti innocenti come “se prendi i voti più alti degli altri a scuola arriverai dove vuoi nella vita” o “non puoi scegliere quella facoltà universitaria anche se ti piace perché puoi arrivare più in alto e avere più successo di così”. Il concetto di dover “fare carriera” grava sulle spalle dei giovani e crea una gabbia soffocante che si manifesta nell’insorgere, sempre più precoce, di sindromi psicologiche come quella da burnout. Pertanto, a chi ricerca la felicità nella ribellione serve una forza mastodontica; infatti, non asservirsi al sistema, seguire le proprie idee, passioni e sensazioni può facilmente causare l'esclusione sociale e una ferita nell’autostima conseguente al crollo del riconoscimento altrui.
Dovrebbe, perciò, esserci insegnato che esiste anche altro, che il lavoro è importante ma che è altrettanto importante nutrire la propria anima, sentirsi in pace e aiutare il prossimo. Dovrebbe esserci spiegato che è importante guadagnare, ma che essere ricchi, avari e soli non è qualcosa da celebrare come un successo. Dovrebbe esserci detto che fare lo sgambetto agli altri, guardare solo a noi stessi e al nostro profitto non ci renderà né bravi, né veramente felici, ma ci porterà solo ad una felicità virtuale, illusoria e temporanea, che deriva dall’aver realizzato ed espresso nel mondo la volontà di qualcun altro e non la nostra. Come ha evidenziato Hegel, siamo esseri relazionali, che hanno strutturalmente bisogno dell’altro e che hanno strutturalmente bisogno di vedere se stessi nella realizzazione di qualcosa di esterno a sé. Questo processo, però, non può e non deve essere alienato, non può e non deve costringerci a barattare la nostra anima e la nostra salute, sia fisica che psicologica, in nome di un denaro da utilizzare all’interno di quello stesso sistema di consumo che ci tiene rinchiusi e che ci rende egoisti, infelici, stressati, ansiosi e che ci vuole tutti ugualmente sottomessi, alienati e silenziosi. “Il lavoro rende liberi” è la frase scritta all'ingresso dei campi nazisti dove furono sterminati milioni di uomini, “Il profitto rende liberi” un'espressione affermata di recente dal dirigente di una nota industria automobilistica. Il confronto fra queste due frasi segnala l’urgenza di risvegliare le nostre coscienze e di liberare noi stessi dalle catene di questo "fare carriera" tossico che, come evidenzia questo paragone, ci annulla come esseri umani.



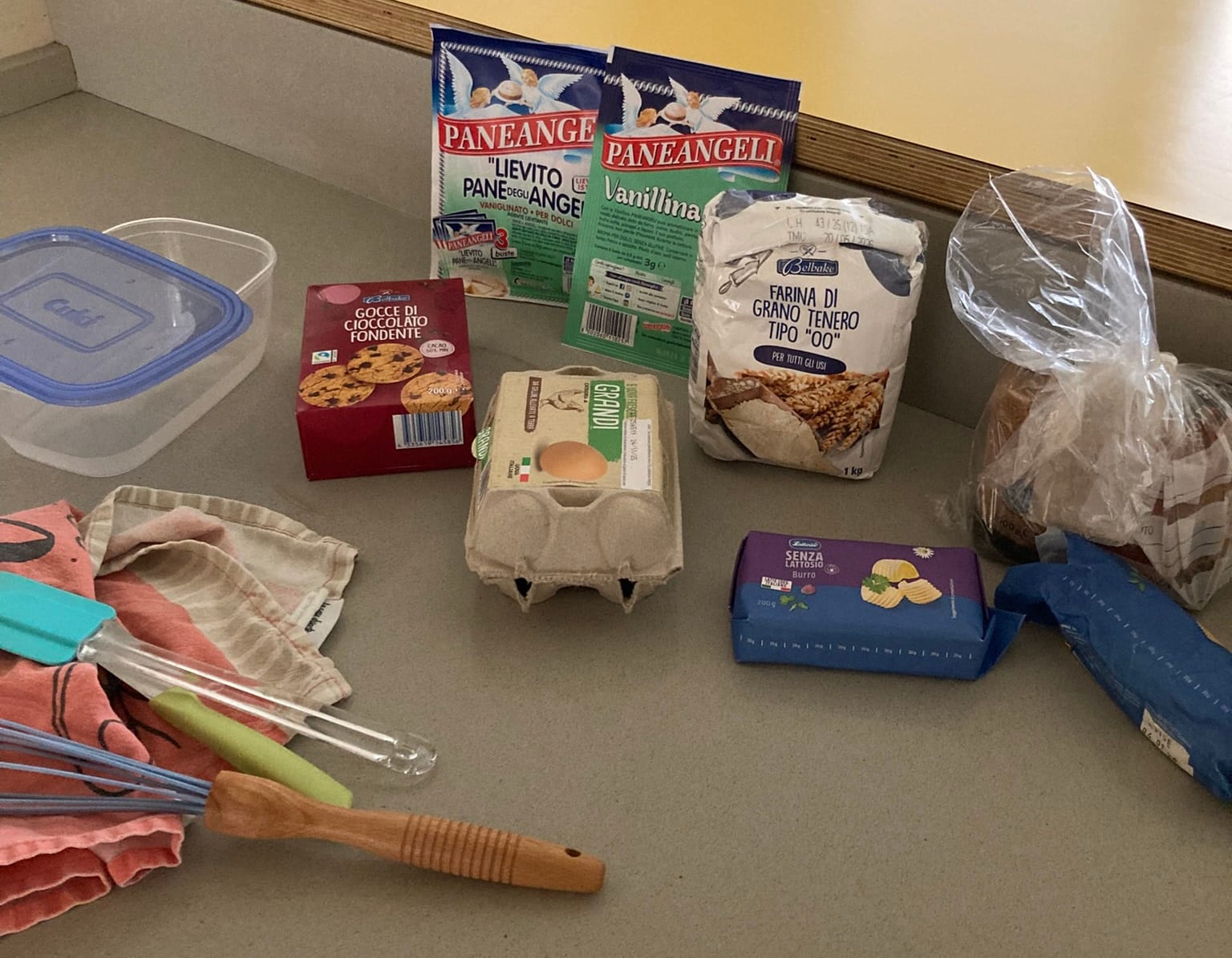
Comments ()